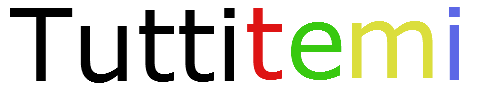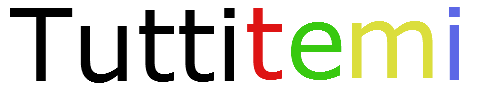|
La venuta di Enrico VII in Italia (1310-1313) e il tramonto dell'Impero.
Mentre il giovane Corrado IV di Svevia muore in Italia nel 1254, la Germania è
ancora tutta sconvolta dalla discordia fra i Guelfi e i Ghibellini, che si
contendono il trono: si può dire che dalla morte di Federico II (1250), per più
di venti anni, la Germania non ha un re universalmente riconosciuto (grande
interregno 1250-1273).
Da
queste lotte civili traggono vantaggio specialmente i feudatari tedeschi e le
varie confederazioni di città libere, che si sono venute formando nella regione
del Reno e verso le coste del Baltico e del Mare del Nord: gli uni e le altre
consolidano i loro possessi territoriali, si rendono sempre più indipendenti, e
contribuiscono a mantenere nella Germania quel
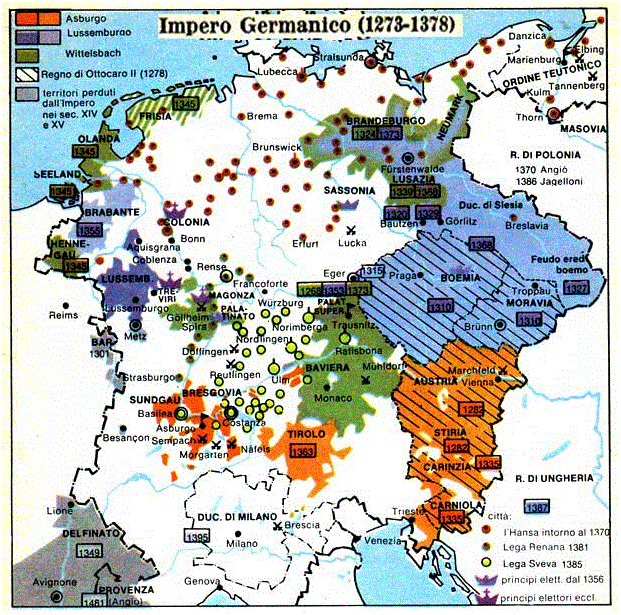 frazionamento feudale, che negli
altri paesi tende invece a scomparire per dar luogo alle grandi monarchie
unitarie. Più tardi il diritto di eleggere il sovrano verrà accentrato nelle
mani di sette grandi elettori, i quali tenderanno ad avere il controllo della
politica imperiale. Scompaiono così quelle forti figure di imperatori assoluti,
che avevano formato la grandezza della Germania medievale, mentre da ora
abbondano scialbe figure di principi, che si muovono a stento fra le difficoltà
create dal controllo dei feudatari tedeschi. frazionamento feudale, che negli
altri paesi tende invece a scomparire per dar luogo alle grandi monarchie
unitarie. Più tardi il diritto di eleggere il sovrano verrà accentrato nelle
mani di sette grandi elettori, i quali tenderanno ad avere il controllo della
politica imperiale. Scompaiono così quelle forti figure di imperatori assoluti,
che avevano formato la grandezza della Germania medievale, mentre da ora
abbondano scialbe figure di principi, che si muovono a stento fra le difficoltà
create dal controllo dei feudatari tedeschi.
In questo periodo si afferma la Casa d'Asburgo nella
persona di Rodolfo I, re di Germania dal 1273 al 1291, il quale, avendo
conquistato l'Austria, la Carinzia e la Stiria, con queste province costruì la
base della grandezza territoriale della sua famiglia, che, lasciato il vecchio
nome di Casa d'Asburgo, prese quello più pomposo di Casa d'Austria. Anche
Alberto I, figlio di Rodolfo, fu eletto re di Germania (1298-1308), ma non
riuscì per allora a rendere ereditaria nella sua famiglia la corona; infatti
alla sua morte fu eletto Enrico VII di Lussemburgo (1308).
L'imperatore Enrico VII di Lussemburgo in Italia (1310-1313)
Il nuovo imperatore, benché di modesta origine feudale, era uomo di idee
grandiose,
sinceramente entusiasta della tradizione imperiale e deciso a farla
prevalere non solo sui principi di Germania, come avevano fatto i suoi
predecessori, ma anche sull'Italia, abbandonata a sé da mezzo secolo. L'impresa
non appariva facile, perché il partito guelfo, per l'appoggio di Roberto d'Angiò,
re di Napoli, succeduto da poco al padre Carlo II (1285-1309), era fortissimo in
Italia, né i Ghibellini potevano offrire aiuti sufficienti al bisogno. Perciò
Enrico VII volle piuttosto presentarsi come principe di pace, desideroso di
ricondurre la calma nelle città sconvolte dai partiti.
Così egli sperava di poter giungere senza gravi ostacoli a Roma, per ricevervi
la corona imperiale con grande solennità: dai tempi di Federico II di Svevia non
c'era più stata in Roma alcuna incoronazione imperiale.
Invocato dai Ghibellini, Enrico VII nell'ottobre del 1310 entrava in Italia con
soli 5000 uomini, pieno di buone intenzioni, ma con scarse probabilità di
successo. Passati i primi entusiasmi, a cui prese parte, insieme con tutti i
fuorusciti di Firenze, guelfi e ghibellini, anche Dante esiliato, l'imperatore
cominciò a capire come fosse ardua la sua azione di pacificatore, quando, presa
la corona d'Italia a Milano nel gennaio del 1311, vide scatenarsi sotto gli
stessi suoi occhi la guerra civile: i Visconti, ghibellini, che egli aveva fatto
rientrare in città per conciliare tra loro i partiti, con un audace colpo di
mano sbalzavano dal potere i guelfi Della Torre e li costringevano all'esilio.
Allora parecchie città della Lombardia, temendo il risveglio del partito
ghibellino, si dichiararono ostili a Enrico VII. Anche Firenze, guelfa e
borghese, si chiuse in una superba diffidenza e promosse una lega di città
toscane contro l'imperatore. E questi, che già aveva nominato vicario imperiale
Matteo Visconti, fu costretto ad affidarsi al partito ghibellino e a combattere
le città guelfe: Brescia fu assediata a lungo, e dopo una fiera resistenza,
presa e saccheggiata.
Intanto a Roma il partito guelfo, ottenuto da Roberto d'Angiò l'invio di un
notevole numero di cavalieri, si preparava ad impedire a Enrico l'ingresso in S.
Pietro.
Infatti nel maggio del 1312 l'imperatore, entrando in città, poté
occupare il Laterano, ma per quanto tentasse con la forza di avviarsi verso la
città Leonina, non vi riuscì, avendo i Guelfi munito il ponte e Castel
Sant'Angelo. L'incoronazione avvenne nella chiesa di S. Giovanni in Laterano, e
fu celebrata da un cardinale, mancando il pontefice, il quale già da sette anni
aveva trasferito la sede del Papato in Francia.
Contro l'imperatore avevano cospirato molto i Fiorentini, i quali, vedendo Pisa
favorire l'Impero e i Ghibellini, si erano alleati con re Roberto d'Angiò, offrendo a
lui la signoria della loro città. Per salvare il proprio decoro, l'imperatore
doveva umiliare Firenze. Ma Enrico VII aveva truppe così scarse, che
quando egli si presentò alle mura della città, i Fiorentini chiusero per
disprezzo le sole porte che erano davanti al campo imperiale, lasciando aperte
le altre al traffico e al pacifico passaggio dei cittadini. E fu necessità
levare l'inutile assedio.
Enrico VII si ridusse a svernare a Pisa. per raccogliere armi ed armati, avendo
in animo di assalire il Regno di Na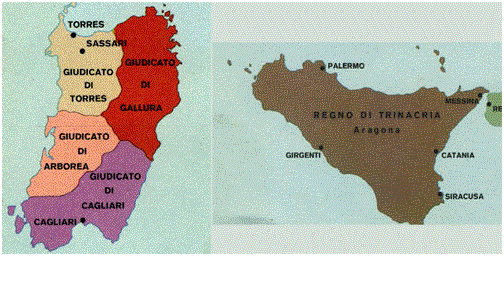 poli e punire re Roberto, capo dei Guelfi e
amico dei Fiorentini: a tal fine si era alleato con Federico, re di Sicilia, e
aveva sollecitato aiuto di navi dalle repubbliche di Genova e di Pisa.
Nell'agosto del 1313, ricevuti rinforzi dalla Germania, si mosse con un esercito
più numeroso verso Roma; ma, giunto a Buonconvento presso Siena, morì di febbre
malarica. I suoi fedeli portarono il cadavere a Pisa, e lo chiusero in un
superbo mausoleo nel duomo: deponendo la salma del loro infelice sovrano, essi
non sapevano di seppellire insieme con quella gli ultimi avanzi della potenza
imperiale in Italia. poli e punire re Roberto, capo dei Guelfi e
amico dei Fiorentini: a tal fine si era alleato con Federico, re di Sicilia, e
aveva sollecitato aiuto di navi dalle repubbliche di Genova e di Pisa.
Nell'agosto del 1313, ricevuti rinforzi dalla Germania, si mosse con un esercito
più numeroso verso Roma; ma, giunto a Buonconvento presso Siena, morì di febbre
malarica. I suoi fedeli portarono il cadavere a Pisa, e lo chiusero in un
superbo mausoleo nel duomo: deponendo la salma del loro infelice sovrano, essi
non sapevano di seppellire insieme con quella gli ultimi avanzi della potenza
imperiale in Italia.
Il pensiero politico italiano.
L'impresa di Enrico VII di Lussemburgo riaccese le dispute fra Guelfi e
Ghibellini e contribuì ad avviare verso un nuovo orientamento il pensiero
politico italiano.
Dante, che aveva auspicato l'arrivo dell'imperatore come di un Messia, scrisse,
forse in quei giorni, il suo trattato "De Monarchia" affermando energicamente
l'origine divina dell'Impero, prestabilito da Dio per la pace del mondo, e
rifiutando la teoria guelfa della supremazia politica del Papato. Nel concetto
dantesco l'Italia appare inquadrata nell'organismo dell'Impero; essa è anzi il
"giardin de lo Imperio" e non deve essere lasciata in abbandono da Cesare, il
quale ha diritto di comandare all'Italia, perché egli è per volere divino
"imperatore dei Romani", cioé degli Italiani. Fin qui Dante si muove entro
l'ambito delle idee medievali, come fanno l'amico Cino da Pistoia e parecchi tra
i glossatori bolognesi. Ma un'Italia, concepita come nazione a sé, etnicamente
unita, vivente la stessa civiltà (sia pure attraverso le diversità regionali) è
apparsa chiara nella mente di Dante. Onde nella coscienza del poeta comincia ad
affiorare il dissidio fra l'universalità dell'Impero e l'autonomia dell'Italia.
Tale dissidio lo risolvono radicalmente i Guelfi, i quali, difendendo le
autonomie comunali contro l'Impero, a poco a poco si abituano a vedere in
Federico Barbarossa, in Federico II, in Enrico VII non l'imperatore romano, ma
il re di Germania.
I Fiorentini, quando chiudono le porte in
faccia ad Enrico VII di Lussemburgo, imprecano, non contro l'imperatore, ma
contro il "rex Alamanniae".
La generazione posteriore a Dante abbandonerà le ideologie medioevali e parlerà
più chiaramente dell'Italia, di un'Italia libera dagli stranieri, arbitra del
suo destino. Tale è il pensiero di Francesco Petrarca nelle due canzoni: "Spirto
gentil" e "Italia mia".
Né diversa é l'idea di Cola di Rienzo, il focoso tribuno che vagheggia insieme
la restaurazione dell'antica Roma e la riscossa d'Italia. Ma il timore
ghibellino di vedere l'Impero asservito al Papato in Roma, farà sorgere un'altra
idea: l'imperatore romano sarà eletto dal suo popolo, cioé non dal papa, ma dal
popolo di Roma, perché non la Germania, non il pontefice, ma il popolo di Roma è
depositario della dignità imperiale. Questa teoria della "sovranità popolare
romana", adombrata in Marsilio da Padova, sarà appunto il sogno di Cola di
Rienzo: egli proclamerà che i barbari stranieri non debbono occupare l'Impero di
Roma; sotto lo scettro d'un imperatore italiano "Roma e la sacra Italia sono da
ridurre ad unione concorde, pacifica, indissolubile".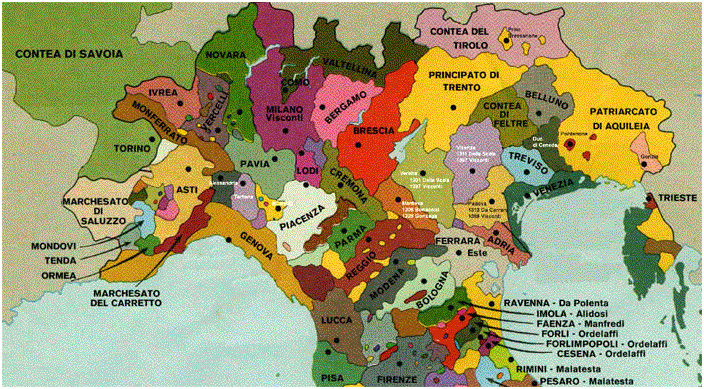
Il Comune di Firenze dalle origini al 1313
Intorno all'anno 1000 la città di Firenze era uno dei tanti centri cittadini del
vasto Marchesato di Toscana.
Cominciò a dare qualche segno di vitalità
politica solamente durante la lotta per le investiture (secolo XI), quando il
popolo fiorentino, condotto da Giovanni Gualberto, fondatore dei Vallombrosani,
iniziò una sorda e lunga battaglia contro il vescovo simoniaco Mezzabarba,
emulando nei metodi i focosi Patarini di Milano.
Morta la contessa Matilde di Canossa (1115) e sfasciatosi il vecchio Marchesato
di Toscana, Firenze rimase, come le altre città circostanti, senza alcun
governo, in mezzo al groviglio delle contese tra Papato e Impero per la
successione ai beni matildini.
Cominciò allora a governarsi da sé, reggendosi a
libero Comune e difendendosi contro i feudatari dei dintorni e contro i vicari
imperiali di S. Miniato al Tedesco. Non prese parte alla lotta, che i Comuni
lombardi ingaggiarono contro Federico Barbarossa; però nel 1197, proprio
all'indomani della morte dell'imperatore Enrico VI, si pose alla testa della
Lega di San Genesio, e con Siena, Volterra, Lucca, mantenne viva in Toscana la
lotta contro l'Impero.
Firenze ebbe dapprima i Consoli; più tardi nominò in loro vece un Podestà, che,
apparso la prima volta nel 1193, dopo l'anno 1207 divenne definitivamente la
principale autorità del Comune, e presiedette ai due Consigli, maggiore e
minore, e al Parlamento del popolo. Nei tempi più antichi il governo del Comune
fu tenuto dai nobili, detti grandi o magnati, tutti feudatari e valvassori,
venuti a vivere in città, e uniti nella potente Consorteria delle Torri; poca
efficacia aveva il popolo, cioè la borghesia degli artigiani e dei mercanti,
sebbene già cominciasse a organizzarsi nelle Arti.
Guelfi e Ghibellini; scissione della nobiltà; il "Primo Popolo" (1250).
Avvenne appunto in quei tempi la famosa divisione fra Guelfi e Ghibellini, a cui
i cronisti diedero come spunto iniziale il romanzesco episodio di Buondelmonte
de Buondelmonti. Aveva costui promesso di sposare una fanciulla degli Amidei, ma
essendosi, pochi giorni prima delle nozze, invaghito di una Donati, e avendola
sposata, i parenti della tradita giurarono di vendicarla, e il giorno di Pasqua
del 1215 uccisero il giovane, che veniva a cavallo nei pressi di Ponte Vecchio.
Da allora tutta Firenze fu scissa in due partiti: sostennero gli uni gli Amidei
e gli Uberti, e furono detti Ghibellini, perché quelle erano famiglie di antica
origine feudale, e amiche dell'Impero; parteggiarono gli altri per i Donati e i
Buondelmonti, e furono detti Guelfi, inclinando essi verso la Chiesa e il
popolo.
 Sotto il racconto forse leggendario dei cronisti si nasconde un episodio grave
per la storia del Comune di Firenze, la scissione della nobiltà cittadina: ne
profitterà la borghesia degli artigiani e dei mercanti, contro la nobiltà
indebolita dalla discordia. Tuttavia il governo rimane ancora in mano ai nobili,
e specialmente ai Ghibellini che, forti dell'appoggio di Federico II,
spadroneggiano in Firenze. Ma il governo ghibellino è duro, prepotente, incapace
di secondare il meraviglioso progresso di Firenze nell'industria e nel
commercio. Alla morte dello Svevo (1250), il popolo delle Arti, che vuole dare
al Comune un orientamento politico decisamente mercantile, compie la sua prima
rivoluzione eleggendo il Capitano del popolo: questi deve circondarsi di armati
e provvedere alla difesa del popolo grasso contro la prepotenza dei nobili. Sotto il racconto forse leggendario dei cronisti si nasconde un episodio grave
per la storia del Comune di Firenze, la scissione della nobiltà cittadina: ne
profitterà la borghesia degli artigiani e dei mercanti, contro la nobiltà
indebolita dalla discordia. Tuttavia il governo rimane ancora in mano ai nobili,
e specialmente ai Ghibellini che, forti dell'appoggio di Federico II,
spadroneggiano in Firenze. Ma il governo ghibellino è duro, prepotente, incapace
di secondare il meraviglioso progresso di Firenze nell'industria e nel
commercio. Alla morte dello Svevo (1250), il popolo delle Arti, che vuole dare
al Comune un orientamento politico decisamente mercantile, compie la sua prima
rivoluzione eleggendo il Capitano del popolo: questi deve circondarsi di armati
e provvedere alla difesa del popolo grasso contro la prepotenza dei nobili.
In questo modo a Firenze, come in tante altre città, si hanno allora due governi,
armati e organizzati, l'uno a fianco dell'altro, l'uno geloso e sospettoso
dell'altro: da una parte il Podestà, che col Consiglio generale e speciale
costituisce il vecchio Comune dominato dai nobili, il solo che ufficialmente
rappresenti lo Stato; dall'altra sta il Capitano del popolo, che si circonda dei
rappresentanti delle Arti.
Non é ancora la conquista del potere da parte della
borghesia, perché continuano a dominare i nobili; ma é un primo passo verso tale
conquista, tanto più che l'audacia del popolo cresce ogni giorno.
Correttamente
quindi gli antichi cronisti fiorentini chiamano questo ordinamento del 1250 il
Primo Popolo, cioé il primo governo popolare in Firenze.
All'audace riforma non si sottomette di buon animo il partito dei grandi, onde i
più intransigenti fra costoro, i Ghibellini, vengono cacciati dalla città
(1251): da questo momento Firenze è la città guelfa per eccellenza.
Alla
sua conquista mira allora re Manfredi, nella sua effimera restaurazione del
partito ghibellino in Italia; perciò manda aiuti di armi e di danaro a Farinata
degli Uberti, capo dei Ghibellini esiliati.
Farinata marcia contro la patria,
vince i Guelfi nella battaglia di Montaperti (1260), entra in città, rovescia il
governo popolare e caccia il partito avversario: Guido Novello, signore di
Poppi, domina in Toscana come vicario di re Manfredi.
Il dispotismo dei nobili fa la sua seconda cattiva prova in una Firenze, che vive
d'industrie e di commerci; morto Manfredi nella battaglia di Benevento, caduto
in tutta Italia il partito degli Svevi, il popolo, aiutato da Carlo d'Angiò, re
di Napoli e capo dei Guelfi, caccia per sempre i Ghibellini da Firenze, e
restaura il governo di parte guelfa (1266).
L'istituzione del Priorato (1282)
Ma ormai Guelfi e Ghibellini sono nomi senza significato. Sotto la contesa
politica si nasconde infatti la solita lotta di classe tra i due maggiori
partiti: i magnati, cioé i nobili e il popolo, cioè la borghesia.
Questa, che già
nel 1250 aveva eletto il Capitano del popolo, nel 1282 fa un secondo passo più
audace, e impone una nuova costituzione, per cui entrano a far parte stabilmente
del governo, accanto al Podestà, anche i Priori delle Arti maggiori (Giudici e Notari, Mercanti di Calimala, Cambiatori, Lanaioli, Mercanti della seta o di Por
S. Maria, Medici e Speziali, Pellicciai e Vaiai). 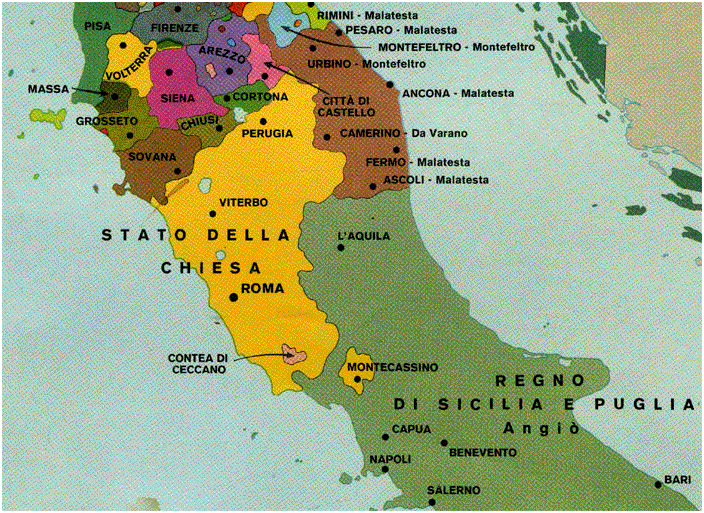
Così con l'istituzione del Priorato sale al potere il popolo, non quello che noi
oggi intendiamo, bensì la parte più ricca della borghesia fiorentina, quella che
fabbrica e smercia i suoi famosi pannilana per tutti i mercati del mondo, che
apre in tutte le maggiori piazze i suoi famosi banchi, e sovvenziona con
prestiti lucrosi la Chiesa romana e le principali corti d'Italia e d'Europa.
La politica di Firenze, guidata da uomini d'affari, assume allora più
decisamente una direttiva affaristica e mercantile. Pisa, al cui porto mirano da
tanto tempo i mercanti fiorentini, desiderosi di uno sbocco al mare, è in guerra
con Genova; Firenze appoggia quest'ultima, e quando Pisa è battuta alla Meloria
dai Genovesi (1284), si fa cedere terre e castelli dalla vinta città.
Ma anche Arezzo è nemica di Firenze e cerca di rovinarne il commercio impedendo
il transito dei pannilana fiorentini verso Roma. Scoppia allora la guerra contro
Arezzo: nel 1289 a Campaldino gli Aretini sono vinti; allo scontro prende parte
anche Dante Alighieri, giovane allora di 24 anni. La pace di Fucecchio, conclusa
con Pisa e Arezzo nel 1293, stabilisce l'esenzione dai dazi delle merci
fiorentine che passano attraverso i territori di quei due Stati, e consacra
definitivamente il predominio politico ed economico di Firenze su tutta la
Toscana.
La vittoria del popolo grasso e gli Ordinamenti di giustizia (1293)
E' giunta l'ora: il popolo grasso, arricchito dai floridissimi affari, tenta il
colpo di mano definitivo contro i grandi, escludendoli dal governo e riservando
a sè soltanto le cariche pubbliche.
Nel 1293, per opera principalmente di Giano della Bella, si approvano i famosi
Ordinamenti di giustizia, coi quali:
-
si ammettono al Priorato solamente coloro che fanno parte delle Arti, cioé la
sola borghesia (esclusi quindi i nobili e la plebe);
-
si chiamano al governo anche i medi e minori artigiani (cioé si allarga la base
del governo borghese con l'ammissione al potere della media borghesia);
-
si stabiliscono gravissime pene contro i grandi, rei di persecuzioni contro il
popolo (cioé si oppone la forza pubblica alla violenza armata dei nobili).
Si fissano allora nuove norme per la elezione dei Priori, si porta il numero
delle Arti a ventuno: sette maggiori, cinque mediane, nove minori; viene
stabilita una nuova carica, il Gonfaloniere di giustizia, che, eletto ogni due
mesi, siede coi Priori, comanda una forte schiera di armati a difesa dei
cittadini delle Arti, e riceve in consegna il gonfalone del popolo. Così la
borghesia schiaccia senza riguardo la nobiltà, e la rende impotente togliendole
ogni influenza politica. E sebbene poco dopo Giano della Bella debba uscire
esule da Firenze, gli Ordinamenti di giustizia rimangono sempre in vigore e
costituiscono il palladio intangibile della ricca borghesia fiorentina.
La scissione tra i Bianchi e i Neri (1300); il priorato di Dante Alighieri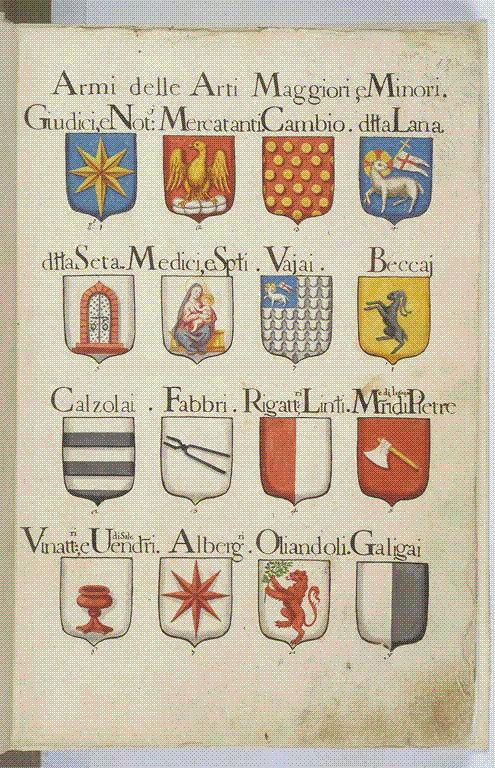
I malcontenti non si rassegnano al trionfo del popolo grasso: nobili, piccoli
artigiani e popolino fanno
lega tra loro per rovesciare il governo della ricca
borghesia.
Serve da pretesto una nuova discordia fra le maggiori famiglie
fiorentine. Intorno al 1300 due grandi casate guelfe si contendono tra loro il
predominio in città: i Cerchi "uomini di basso stato, ma buoni mercatanti e gran
ricchi" (dice Dino Compagni), dei quali è capo messer Vieri de' Cerchi, e i
Donati "più antichi di sangue ma non sì ricchi", obbedienti tutti a Corso
Donati, uomo che per audacia e superbia è da tutti ammirato e temuto. Intorno a
queste due famiglie si vengono orientando i cittadini; quelli che stanno per i
Cerchi si dicono Bianchi; quelli che sono per i Donati si chiamano Neri. Questa
denominazione di Bianchi e Neri pare sia stata introdotta a imitazione dei due
partiti in cui era divisa la nobile famiglia dei Cancellieri di Pistoia; ad ogni
modo essa comincia a divenire di uso generale in Firenze dopo il 1300, quando
nell'occasione delle feste di calendimaggio di quell'anno, i Cerchi e i Donati
arrivano a una serie di scontri sanguinosi, dividendo la città in due fazioni,
che si combattono come prima hanno fatto Guelfi e i Ghibellini.
Ma anche questa volta sotto una competizione gentilizia si nasconde la lotta di
classe; i Cerchi, mercanti arricchiti, raccolgono intorno a loro le simpatie del
popolo grasso, quello precisamente che dopo gli Ordinamenti di giustizia è al
potere; i Donati, nobili di origine e fieramente avversi al popolo grasso, che
li ha allontanati dal potere, si vantano difensori delle antiche aspirazioni
nobiliari, mai tramontate, e si fanno forti dell'appoggio della parte del popolo
minuto esclusa dal governo. Sono dunque bianchi i borghesi delle Arti maggiori;
sono invece neri i nobili, i piccoli artigiani e i proletari.
Ed ecco in mezzo a tante discordie levarsi minacciosa la figura di papa
Bonifacio VIII, il quale vuol far valere la supremazia politica del Papato anche
sui Fiorentini, tanto più che la Toscana è un vecchio feudo della contessa
Matilde, su cui il Papato vanta qualche diritto: egli si accorda segretamente
con Corso Donati e coi Neri per scalzare la Signoria, che è bianca e custodisce
gelosamente la libertà comunale.
Col pretesto di pacificare Firenze viene
mandato il Cardinale d'Acquasparta, il quale non riesce che ad acuire gli odi
fra le due fazioni, tanto che la Signoria, di cui fa allora parte anche Dante
come Priore, è costretta a bandire dalla città i maggiorenti dei due partiti
(1300). Ma poco dopo i Bianchi rientrano col tacito consenso della Signoria, che
è loro favorevole, mentre i Neri di fuori si raccomandano al papa, il quale
invia come «paciaro» Carlo di Valois, fratello del re di Francia.
La Signoria
non s'illude sulla missione di lui; sa bene che egli viene per "abbattere il
popolo e parte bianca"; perciò si raduna nervosamente per difendere gli
Ordinamenti di giustizia, si abbandona a rappresaglie contro gli amici dei Neri
e invia a Bonifacio VIII alcuni ambasciatori, fra cui anche l'Alighieri.
Intanto Carlo di Valois entra in Firenze e dà man forte a Corso Donati, che in
mezzo ai suoi varca la porta, da cui è partito esule, e traversa altezzosamente
la città, tra la plebe che lo applaude al grido di "viva il barone!".
Incominciano le vendette: i Neri s'impadroniscono della Signoria e mandano in
esilio, uno dopo l'altro, seicento ricchi e cospicui cittadini di parte bianca,
tra i quali Dante Alighieri (1302). Ma l'intollerabile superbia di Corso Donati
e l'insolenza della plebe risvegliano il popolo grasso, il quale, dopo qualche
anno di lotta, riesce a riconquistare il potere e ad uccidere Corso Donati
(1308).
La borghesia trionfa, ma agli esuli del 1302 nega il permesso di rientrare in
Firenze. Costoro, guelfi, hanno fatto lega coi fuorusciti ghibellini, e insieme
ad essi hanno tramato contro il Comune. Restano dunque fuori, a scrutare se da
lontano giunge in loro aiuto il tanto sospirato imperatore. E anche Dante non
può tornare.
L'infelice impresa di Enrico VII e il perenne esilio di Dante
Dopo la morte di Corso Donati, ecco nel 1310 apparire all'orizzonte politico
d'Italia l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo: su lui si appuntano le speranze
dei Ghibellini di tutta Italia; a lui si dirigono le suppliche degli esuli di
Firenze, con Dante alla testa, che saluta nell'imperatore il principe di
pace. Il fallimento dell'impresa di Enrico VII e la rapida fine di lui (1313)
lasciano inalterate le condizioni dell'Italia e di Firenze in particolare.
I fuorusciti,
ghibellini e bianchi, perdono ogni speranza di ritorno; Dante trascina ancora,
lungi dal suo "bel san Giovanni", gli ultimi anni della sua triste vita di
esule.
La Repubblica di Venezia ; lotte con Genova per il predominio nel Levante
In mezzo al turbine delle guerre e delle discordie, che agitano l'Italia nei
secoli XIII e XIV, Venezia appare come un'oasi di tranquillità e di benessere.
Senza dubbio Venezia non avrebbe potuto prosperare così, se non avesse avuto
quel suo famoso governo oligarchico che, unico in Italia e forse nel mondo,
diede per tanti secoli lo spettacolo della più illuminata energia. La repubblica
non ebbe mai una vera nobiltà feudale, poiché nelle sue isole non vennero ad
abitare né feudatari vinti, né vassalli del contado, come nei Comuni di
terraferma; a Venezia chi prese in mano il governo della cosa pubblica fu un
piccolo gruppo di cittadini, scelti fra quelle famiglie, che coi traffici si
erano maggiormente arricchite. Così verso il secolo XII cominciò ad adunarsi il
Maggior Consiglio, composto di 480 consiglieri, che avocò a sé gran parte delle
prerogative dell'assemblea popolare.
Più tardi si venne formando il Minor Consiglio o Senato composto dei Pregadi, i
quali avevano l'ufficio di assistere nelle sue deliberazioni il Doge. Questi era
eletto a vita; perciò la sua scelta veniva fatta con cura e attraverso minuziosi
controlli; la sua autorità era poi limitata dalla assistenza dei sei
Consiglieri, che gli sedevano sempre a fianco; e insieme con lui e coi tre Capi
della Corte d'Appello costituivano la Serenissima Signoria.
L'oligarchia veneziana, non contenta di avere il controllo del governo, volle
con un colpo di Stato assicurarsi il perpetuo dominio della repubblica; infatti
nel 1297 essa riuscì a imporre la famosa Serrata del Maggior Consiglio, con la
quale limitava il diritto di entrare in quel consesso solamente a coloro che vi
avessero seduto negli ultimi quattro anni, o i cui antenati vi avessero
precedentemente appartenuto. Così una minoranza si impadronì per sempre del
potere, trasformò la repubblica in un'oligarchia chiusa, ed escluse tutti gli
altri cittadini da ogni partecipazione al governo. Fu compilato l'elenco delle
famiglie privilegiate con la nota dei matrimoni e delle nascite, elenco che poi
fu detto il Libro d'oro.
La famosa nobiltà veneziana ha una tale origine.
Naturalmente ciò non poté
avvenire senza provocare una reazione da parte degli esclusi, alla testa dei
quali si pose nel 1310 Baiamonte Tiepolo.
La ribellione fu soffocata nel sangue,
e da allora la gelosa nobiltà istituì quel Consiglio dei Dieci, coi relativi tre
Inquisitori, che é certamente il più formidabile tribunale politico del medio
evo.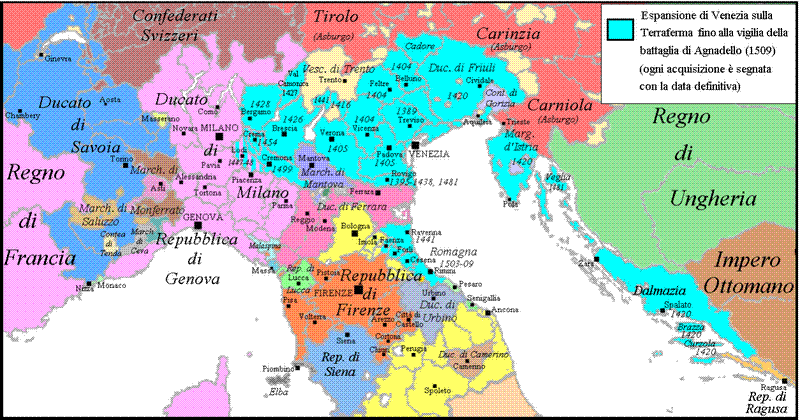
Il possesso dei mercati del Levante; rivalità e lotte con Genova.
La tranquillità interna permise alla repubblica di curare in modo specialissimo
tutto il mondo coloniale e i vecchi e nuovi mercati. La quarta Crociata
(1202-1204) e il successivo acquisto di gran parte delle isole e dei porti
dell'Egeo e dello Ionio, avevano dato a Venezia il primato nei mari del Levante
e il quasi assoluto monopolio dei prodotti orientali. Tutti gli anni,
all'aprirsi della primavera, una grossa flotta mercantile partiva per i mari del
Levante, toccava i porti più attivi e tornava in settembre, carica di spezie,
sete, tappeti, broccati e damaschi levantini; un'altra partiva in agosto,
svernava fuori e ricompariva verso maggio; il loro arrivo era il momento del
massimo risveglio commerciale della città, alla quale affluivano i mercanti di
ogni paese per gli acquisti immediati.
Il predominio nel Levante costituiva la
fonte maggiore della ricchezza veneziana, onde è naturale che i Genovesi
tentassero tutti i mezzi per strappare ai rivali questo prezioso primato,
cercando di colpire specialmente là, dove più vitali erano gli interessi
veneziani, cioè a Costantinopoli.
L'Impero Latino d'Oriente, fondato dai Veneziani nel 1204, era sempre rimasto un
povero Stato feudale, combattuto a nord dai Bulgari, e a sud dall'lmpero di
Nicea, piccolo Stato greco, formatosi nell'Asia Minore. Tuttavia i Veneziani
erano riusciti a conservare intatti i loro privilegi, sì che essi, annientata la
concorrenza dei Genovesi e dei Pisani, avevano il monopolio del commercio nel
porto di Costantinopoli, controllando tutti i traffici dell'Egeo e del Mar Nero.
I Genovesi, colpiti così nei loro interessi, vollero ad ogni costo soppiantare i
Veneziani; non c'era che una via: favorire le aspirazioni di Michele Paleologo,
imperatore di Nicea, aiutarlo nella conquista di Costantinopoli, abbattere
l'Impero Latino, ricostruire il vecchio Impero Bizantino, e da questo ottenere
privilegi e concessioni identiche a quelle che godevano i Veneziani. Ciò fecero
i Genovesi firmando con Michele Paleologo nel 1261 il Trattato di Ninfeo (Asia
Minore), e offrendogli la loro flotta per compiere l'impresa vagheggiata.
Infatti nello stesso anno Costantinopoli era presa; l'Impero Bizantino risorgeva
con Michele VIII Paleologo; questi fondeva le nuove conquiste col suo Stato di
Nicea, costituendo un Impero di notevoli dimensioni, senza riuscire però a
riprendere le isole dell'Egeo, difese strenuamente dai Veneziani. Ma intanto
Genova cacciava i Veneziani dal loro quartiere di Costantinopoli, demoliva le
loro fortificazioni e occupava il sobborgo di Galata, che divenne il cuore del
commercio genovese nell'Egeo e nel Mar Nero.
Naturalmente la lotta fra le due repubbliche rivali si acuì al punto, da
presentare spesso l'aspetto più di una impresa da corsari che di una guerra tra
popoli civili.
Innumerevoli furono le battaglie navali, nelle quali purtroppo si
venne logorando la potenza italiana sul mare; di queste battaglie la più
memorabile è quella di Curzola (a sud-est di Lissa) del 1298, in cui
l'ammiraglio genovese Lamba Doria riuscì a distruggere l'armata veneziana,
facendo un gran numero di prigionieri, tra i quali fu anche il famoso
viaggiatore Marco Polo. Ma la potenza di Venezia aveva troppo salde radici
perché una battaglia perduta potesse umiliarla: infatti quando, auspice Matteo
Visconti, nel 1299 si firmava la pace a Milano, i vantaggi ottenuti dai Genovesi
apparvero ben scarsi in confronto dei loro successi militari.
La Repubblica di Genova: lotte con Pisa e con Venezia.
La storia di Genova è strettamente legata a quella delle sue classiche rivali,
Pisa nel Tirreno e Venezia nei mari del Levante.
Con Pisa i rapporti erano stati buoni nei primi tempi, quando le due repubbliche
si erano unite più volte per lottare contro i Saraceni; ma più tardi, a causa
del possesso delle isole maggiori del Tirreno, le rivalità si accesero e
degenerarono in guerre disastrose.
Così mentre Pisa si accostava al partito
ghibellino, favoriva il Barbarossa e più tardi, alleata di Federico II, batteva
i Genovesi nello scontro navale dell'isola del Giglio (1241), Genova appoggiava
la parte guelfa, aiutava i Comuni e papa Alessandro III, e più tardi riusciva a
trasportare Innocenzo IV e i suoi prelati in Francia a quel Concilio di Lione,
che fu la disfatta di Federico II e della parte ghibellina in Italia.
Ma l'occasione per vendicare la sconfitta del Giglio si presentò presto ai
Genovesi. Nel 1282 la Corsica, soggetta a Genova, si agitava contro la madre
patria, aiutata sottomano dai Pisani, i quali, possedendo già la Sardegna,
volentieri avrebbero occupato anche l'altra isola. Ne nacque una guerra
tremenda, che culminò nella famosa battaglia navale alla Meloria (1284), nella
qu ale i Pisani furono disfatti, abbandonando ben 10.000 prigionieri, molti dei
quali delle migliori famiglie pisane, onde venne il motto: "chi vuoi veder Pisa
vada a Genova". ale i Pisani furono disfatti, abbandonando ben 10.000 prigionieri, molti dei
quali delle migliori famiglie pisane, onde venne il motto: "chi vuoi veder Pisa
vada a Genova".
Allora i Guelfi di Toscana, alleati dei Genovesi, minacciarono
la marcia su Pisa; Ugolino della Gherardesca, eletto capitano del popolo, salvò
la repubblica cedendo terre e castelli a Lucca e a Firenze, che si erano levate
in armi, e cacciando i Ghibellini: ne ebbe più tardi in compenso la taccia di
traditore e la morte per fame nella torre (cfr. Inferno, XXXIII). Ma dopo la
Meloria, Pisa non si rialzò più, e Genova ottenne parte della Sardegna e il
dominio assoluto sul Tirreno.
Meno felice fu la lotta con la più formidabile nemica dell'Adriatico, Venezia.
Rimase tuttavia a Genova un bel campo di attività mercantile nel Mar Nero, dove
essa ebbe il primato indiscusso fino alla presa di Costantinopoli, fatta dai
Turchi nel 1453. Il traffico genovese proseguì a mantenersi vivacissimo per
qualche secolo ancora per tutto il Mediterraneo occidentale, e altissima si
conservò la fama dei Liguri come costruttori di navi, esperti piloti, audaci
navigatori. Né minore fu la celebrità di Genova nel mondo finanziario, in mezzo
al quale il famoso Banco di San Giorgio seguitò ad essere uno dei più forti
istituti di credito fino a tutto il secolo XVI.
Papa Celestino V (1294)
Nel 1292 muore il papa Nicolò IV
(1288-1292). I cardinali, divisi in tanti partiti (partito dei Colonna, partito
degli Orsini, partito angioino), si radunano a conclave, senza però riuscire ad
eleggere il nuovo pontefice. Moltiplicano le sedute a Roma, a Perugia, per ben
ventisette mesi, ma sempre invano, tanto è profonda la divisione degli animi.
Allora un gruppo di cardinali propone di nominare papa un uomo completamente
estraneo alle competizioni e universalmente conosciuto per la santità dei
costumi. Non lontano da Sulmona, presso la Maiella, vive da anni un eremita: lo
chiamano Pietro da Morrone, e alberga in una misera capanna, dove si sostenta
con poco cibo e vive in contemplazione.
Le folle ne decantano i miracoli e vengono alla sua cella in pellegrinaggio, per
raccomandarsi alle sue preghiere e alla sua santità. A lui dunque si volge il
pensiero dei cardinali, che lo eleggono papa senza interpellarlo.
Un fantastico
corteo di prelati, di baroni, di popolo sale sulla Maiella, giunge alla povera
capanna, s'inginocchia, annunciando la grande notizia.
L'eremita non comprende
dapprima, poi protesta che non accetterà mai un così grave incarico. Pressato
dalle insistenze di tutti, si rassegna al volere dei cardinali, scende dal monte
e su di un modesto asinello, alle cui briglie sono il re di Napoli Carlo II e
suo figlio, entra in Aquila, dove, alla presenza di una folla plaudente, é
consacrato papa col nome di Celestino V (1294). Al governo della Chiesa è un
uomo che viene da quell'umile ambiente di povertà da cui sono sorte le maggiori
opposizioni alla potenza politica del Papato.
L'esperimento fallisce.
Il nuovo papa non é che un povero eremita, semplice e
buono, ma completamente ignaro dei subdoli raggiri della vita di governo, per
cui diviene uno strumento passivo della prepotenza di Carlo II, che se lo porta
a Napoli, e lo tempesta di sempre nuove richieste. Ed egli, che in cuor suo
rimpiange la solitudine della montagna, resiste sempre meno, finché si lascia
andare a favori, benefici, nomine, prodigandole con una spaventosa incoscienza,
che minaccia di porre la Chiesa a soqquadro. Finalmente comprende l'abisso,
verso il quale cammina, e se ne ritrae spaventato. Chiede ai giuristi se un papa
può rinunciare; avutane risposta affermativa, depone la tiara, e, dopo quattro
mesi di inglorioso pontificato, ritorna ad essere un povero monaco.
Il pontificato di Bonifacio VIII (1294-1303)
ll successore era pronto: il cardinale Benedetto Caetani, favorito dal re di
Napoli, fu eletto papa col nome di Bonifacio VIII (1294-1303). Pochi pontefici
furono tanto odiati e perseguitati da pubbliche accuse. A lui i nemici
rimproverarono complotti contro Celestino, costumi inadeguati, un'occulta
miscredenza. Non è facile discernere la verità. Certamente Bonifacio VIII ebbe
carattere aspro, violento, ambizioso; fu però anche uomo d'ingegno e di cultura,
studioso di legge e filosofia.
Difese energicamente la supremazia politica del Papato, secondo il programma di
Gregorio VII e di Innocenzo III, e per questo subì rovesci diplomatici, guerre
penose, insulti ed umiliazioni.
Non aveva compreso che i tempi erano cambiati, e la missione politica del Papato
si esauriva con la fine del medioevo.
Nel gennaio del 1295 da Napoli, dove aveva avuto luogo il conclave, Bonifacio
VIII entrava in Roma solennemente, su una bianca chinea, tenuta per le redini
dal re Carlo ll, vassallo della Chiesa, e da Carlo Martello suo figlio,
accompagnato da un gran corteo di prelati, di nobili e di popolo.
Suo primo pensiero fu di catturare Celestino, che molti fautori si ostinavano a
voler riconoscere come papa; lo fece inseguire e rinchiudere nel castello di
Fumone, presso Alatri, dove lo tenne fino alla morte, avvenuta nel 1296.
Il
pericolo di uno scisma era evitato, ma intanto Bonifacio si era inimicato i
partigiani dell'infelice monaco.
Sgombrato il terreno da ogni preoccupazione ecclesiastica, Bonifacio VIII si
accinse a realizzare il suo sogno di dominio politico. S'intromise negli affari
del Regno di Napoli, cercando di decidere in favore dei re Angioini la guerra,
allora scoppiata con gli Aragonesi della Sicilia; non riuscì che a metà,
concludendo la pace di Caltabellotta (1302), la quale, più che una vittoria del
Papato, è un compromesso.
S'impicciò nelle faccende del Comune di Firenze, vi inviò Carlo di Valois col
pretesto di favorire la pacificazione dei partiti, ma di fatto col proposito di
appoggiare i Neri e di espellere i Bianchi. In Roma affrontò la potentissima
famiglia dei Colonna, i quali parteggiavano per Celestino; contro di essi bandì
una Crociata, promettendo indulgenze a chiunque vi prendesse parte; occupò le
loro terre, e, costretti i maggiorenti dei Colonna a venire umiliati ai suoi
piedi, ne confiscò i beni, distruggendo il loro castello di Palestrina.
La contesa tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello, re di Francia.
Gli odi che con la sua politica si attirò Bonifacio VIII, furono grandissimi:
Dante, cacciato da Firenze per causa sua, ebbe per lui parole roventi
d'esecrazione. Ma chi gli resistette a viso aperto fu il re di Francia, Filippo
IV il Bello. Trovandosi allora in lotta con l'Inghilterra e avendo bisogno di
molto danaro per le spese di guerra, il re colpì con fortissime imposte i beni
della Chiesa di Francia. Bonifacio VIII protestò contro questa violazione dei
privilegi ecclesiastici e minacciò di scomunica chiunque osasse porre la mano
avida sulle ricchezze della Chiesa.
Filippo il Bello rispose alle minacce papali vietando l'esportazione di danaro,
di pietre preziose, di oggetti costosi, impedendo così che le decime, pagate
alla Curia romana dalla Chiesa di Francia, arrivassero al papa. Il danno subito
dall'amministrazione pontificia e dai banchieri fiorentini, che erano i
mediatori in questi affari, indusse il papa a un'azione più blanda.
La contesa, sopita per qualche anno, si, ridestò nel 1301 quando Filippo il
Bello cominciò addirittura a incamerare le rendite dei vescovati vacanti e pose
i beni della Chiesa sotto il controllo di un'amministrazione di Stato. Bonifacio
VIII riprese le precedenti lagnanze e di nuovo minacciò di scomunicare il
sovrano. Questi, di rimando, convocò gli Stati Generali, cioè l'assemblea dei
rappresentanti del clero, della nobiltà, della borghesia, denunciò le gravi
usurpazioni tentate dal papa contro il potere del re, e ottenne il consenso di
tutta la nazione.
Così Filippo il Bello poté unirsi ai nemici del papa, proteggere i fuggiaschi
Colonna, lavorare occultamente alla rovina del pontefice. Bonifacio VIII però
non era uomo da accettare imposizioni: alla guerra che gli si offriva, rispose
con la guerra.
Pubblicò allora la sua famosa bolla Unam Sanctam, nella quale
arditamente sfoggiava di fronte al re francese il classico programma della
supremazia politica del Papato: "la società costituisce un solo corpo, cioé la
Chiesa, con un solo capo, cioé il pontefice; due sono i poteri o "le spade",
spirituale e temporale; il primo potere è superiore al secondo; la Chiesa
impugna essa sola la spada spirituale, e concede che il re adoperi la spada
temporale, ma solo secondo i fini della Chiesa e in omaggio al volere del
sacerdozio (ad nutum sacerdotis)". Un concilio, tenuto in Roma, aveva intanto
giudicato il re di Francia: la scomunica papale era imminente; con essa sarebbe
stata proclamata la deposizione di Filippo il Bello.
La contesa fra il re e il papa aveva suscitato in Francia un nugolo di polemiche
e di scritti sulla questione dei due poteri. Ma a rompere gl'indugi e a passare
violentemente ai fatti contribuì l'intervento di Guglielmo di Nogaret, dottore
di leggi all'Università di Tolosa, il quale, discendente da un'antica famiglia
di Albigesi perseguitati, covava da anni un odio cupo contro il Papato e la
Chiesa. Egli indusse Filippo il Bello a convocare un concilio in Francia per
eleggere un nuovo pontefice, essendo Bonifacio usurpatore della Santa Sede,
simoniaco, spergiuro, reo di ogni delitto. Lo stesso Nogaret avrebbe trascinato
il colpevole in Francia, davanti al concilio.
L'oltraggio di Anagni e la morte di Bonifacio VIII (1303)
ll 7 settembre 1303 Guglielmo di Nogaret, accordatosi coi Colonna, entra con una
schiera di armati in Anagni, dove si trova il papa, e spaventato il popolo, si
dirige verso il palazzo pontificio. Le porte vengono abbattute, gli sgherri
entrano urlando, con le spade in pugno: Bonifacio VIII li attende intrepido sul
trono, vestito degli abiti sacri; insultato, risponde con dignità e fermezza. Si
disse poi che Sciarra Colonna, spinto dall'odio verso colui che aveva disperso
la sua famiglia, gli desse sul viso un duro schiaffo con la mano coperta dal
guanto di ferro: l'insolenza volgare suscitò lo sdegno dello stesso Dante
(Purgatorio, XX, 86-93)
Fatto il colpo, il Nogaret si accorse come fosse impossibile trascinare il papa
prigioniero attraverso tutta l'Italia, ed esitò. Il popolo d'Anagni il 9
settembre corse a liberare il pontefice, e costrinse i ribaldi alla fuga.
Quattrocento cavalieri romani ricondussero nella città eterna Bonifacio VIII,
offeso, ma non vinto. Poco dopo però, scosso dalle emozioni e logorato dagli
anni, moriva (11 ottobre 1303).
Con lui si spegneva l'ultimo dei papi medioevali della grande scuola di Gregorio
VII; ma l'umiliazione di Anagni chiudeva assai tristemente quel periodo di
supremazia politica, che si era iniziato nel 1077 col trionfo di Canossa. Rimase
però intatta al Papato la sua grande forza religiosa, e ne fu una prova il
Giubileo, bandito la prima volta da Bonifacio VIII nel 1300, a cui convennero da
ogni parte del mondo turbe di pellegrini, ansiosi di visitare le basiliche degli
apostoli e di lucrare le molte indulgenze largite dal papa.
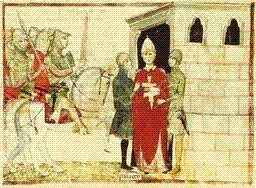
Enormi somme di danaro furono offerte in quella occasione alle chiese romane e
al pontefice, il quale se ne servì per grandi lavori nelle basiliche romane e
nel palazzo del Laterano. E i pellegrini allora per la prima volta videro il
papa coronato con un diadema di nuova foggia, ornato cioé di due corone,
sovrapposte l'una all'altra, in segno della superiorità del pontefice su ogni
sovrano della terra. Più tardi una terza corona si aggiunse alle due, e la tiara
papale ebbe il nome di triregno.
I papi in Avignone (1305-1377) - Il breve pontificato di Benedetto XI (1303-1304)
Morto papa Bonifacio VIII (1303), il Collegio dei cardinali elesse come
successore il pio Nicola Bocchini, generale dei Domenicani, il quale prese il
nome di Benedetto XI. Benché più conciliante di Bonifacio VIII e propenso ad un
accordo con Filippo il Bello, il nuovo pontefice non volle lasciar passare
invendicato l'insulto di Anagni, al quale egli stesso aveva coraggiosamente
assistito, e colpì con la scomunica il Nogaret e Sciarra Colonna, invitando a
comparire davanti al suo tribunale tutti coloro che avessero preso parte a quel
fatto delittuoso. Perciò si ritrasse in Perugia, lontano dall'influenza dei
partiti, e già stava per affrontare con energia il ridestarsi delle opposizioni
antipapali, quando, dopo appena pochi mesi di pontificato, morì nel luglio del
1304.
Il Papato trasporta la sua sede in Francia: la cattività avignonese
(1305-1377)
Il nuovo conclave si svolse fra continui turbamenti: nello Stato Pontificio si
combattevano gli Orsini, i Colonna, i Caetani; Filippo il Bello parteggiando per
i Colonna, se ne serviva per influire sull'animo dei cardinali, che, divisi essi
pure in due partiti, l'italiano e il francese, per parecchi mesi non riuscirono
a mettersi d'accordo sulla elezione del papa. Finalmente decisero di scegliere
anche questa volta un estraneo al Sacro Collegio e, cedendo alle insinuazioni
del re, elessero proprio un francese, Bertrand de Got, arcivescovo di Bordeaux,
che prese il nome di Clemente V (1305). Questi, invece di andare a Roma, ordinò
ai cardinali di venire a consacrarlo in Francia. La coronazione avvenne di fatto
a Lione, alla presenza di Filippo il Bello, di Carlo di Valois e di tutti i più
grandi signori del regno; fu però funestata da un grave incidente, perché
durante la processione rovinò un muro, trascinando nella caduta molti spettatori
e lo stesso papa, che cadde da cavallo e per poco non rimase ucciso: la folla
superstiziosa vide in questo fatto il pronostico di un pontificato infelice. Il nuovo papa non mostrò alcun desiderio di andare a stabilirsi a Roma, dove la
vita era assai difficile per le continue lotte civili; dopo aver peregrinato un
po' qua e un po' là, nel 1309 pose sede stabile ad Avignone, con grande scandalo
della cristianità.
Così nel 1305 comincia per il Papato il periodo della
cattività avignonese (1305-1377)
Questo per la Chiesa fu un periodo di servitù, a vantaggio della Francia, la
quale parve disporre del Papato come di un organo di Stato. Primo a dare un
esempio di tale asservimento alla Francia fu papa Clemente V. Egli, debole,
irresoluto, senza idee, cedette a tutte le richieste di Filippo il Bello,
disdicendo quanto Bonifacio VIII aveva fatto, ritirando la bolla Unam Sanctam,
rinunciando alla punizione dei colpevoli dell'insulto di Anagni, restituendo i
beni ai Colonna, i benefici ai prelati, colpiti dalle sanzioni di Bonifacio VIII
e di Benedetto XI.
Ugualmente poco decorosa fu la condotta del papa nell'affare dei Templari.
Questo celebre Ordine cavalleresco, dopo la perdita di Gerusalemme, si era
ritirato in Europa, aprendo case in parecchi Stati e accumulando grandi
ricchezze, specialmente in Francia, dove il "Tempio", cioé la residenza del Gran
Maestro a Parigi, poteva dirsi una vera reggia. Perduto ormai lo scopo della
loro istituzione, i Templari, profittando della disseminazione delle loro case
in Europa, si erano dedicati agli affari, prestavano danaro, trafficavano, si
arricchivano sempre più. Si parlava volentieri in Francia dell'immoralità dei
Templari. Filippo il Bello, che aveva posto l'occhio su tante ricchezze, esagerò
queste voci, mise in giro calunnie, arrestò parecchi Templari e impose al papa
la soppressione dell'Ordine. Dopo molte titubanze Clemente V cedette, e nel
Concilio di Vienne (1312), contro il parere di molti, condannò i Templari come
empi ed eretici, li soppresse e passò i loro beni agli Ospitalieri.
Filippo il Bello poté per parecchi anni trattenere le pingui rendite dei
Templari, mentre faceva ardere sul rogo più di cinquanta cavalieri, tra i quali
era lo stesso Gran Maestro dell'Ordine.
Clemente V in Avignone ribadì le catene del Papato, nominando in gran numero
cardinali francesi; i suoi successori, quasi tutti francesi anch'essi, lo
imitarono, rendendo così sempre più difficile il sollecito ritorno dei papi alla
loro sede. La tradizione romana del Pontificato si affievolì.
Santa Caterina da Siena e il Petrarca non si stancarono mai di esortare i papi a
ritornare in Roma, pregandoli di considerare quale enorme danno recasse alla
Chiesa l'allontanamento del pontefice dalla sua sede naturale. Infatti,
diminuito il prestigio morale del Papato, venne meno a poco a poco anche il
senso dell'unità della Chiesa, onde i germi di autonomia religiosa, nascosti in
fondo alla nascente coscienza nazionale dei vari popoli, cominciarono ad
apparire, per svolgersi più tardi nello scisma e nell'eresia.
Squallore dello Stato Pontificio
Tristissima allora divenne la condizione dello Stato Pontificio, nelle cui città
da parecchio tempo spadroneggiavano potenti famiglie, tutte intente a formarsi
una stabile signoria a detrimento dei diritti del Papato. A Roma poi, dove il
Comune non era mai riuscito ad avere una vitalità paragonabile a quella dei
Comuni dell'Italia settentrionale, la partenza dei papi segnò il periodo più
acuto della lotta tra le maggiori famiglie, che si contendevano con le armi il
possesso della città.
Deserto il palazzo papale del Laterano, partiti col papa i
cardinali e la corte, diminuiti di numero e d'importanza gli uffici della Curia,
annientato l'afflusso dei pellegrini, Roma decadde rapidamente e si spopolò.
Erano i giorni in cui Dante invocava l'avvento di un forte imperatore in questa
povera Italia, che le discordie civili e l'abbandono dei papi avevano ridotta
come "nave senza nocchiero in gran tempesta".
La lotta fra il Papato e l'imperatore Lodovico il Bavaro
Durante il periodo della cattività avignonese (1305-1377) il Papato si dibatte
in gravi strettezze finanziarie, perché privo di gran parte dei redditi dello
Stato Pontificio; perciò é costretto a:
aumentare le tasse per gli affari
religiosi,
imporre nuove gravezze ai benefici ecclesiastici,
premere sempre
più forte sui fedeli per ottenere decime ed offerte.
Rinascono allora contro la
Chiesa le vecchie accuse di simonia, di avidità, di mondanità, e si destano
diffidenze nei sovrani, i quali, preoccupati del carattere francese del Papato,
cominciano a vedere in questo danaro, che emigra ad Avignone, una specie di
tributo verso la monarchia francese.
Mentre il Papato si rimpicciolisce in un indecoroso vassallaggio e si fa
sentire sui popoli più come esattore di imposte, che come maestro di fede e di
virtù, tutta la Chiesa perde sempre più la stima generale. Anche la disciplina
ecclesiastica, che le rigide riforme di Gregorio VII e di Innocenzo III avevano
tentato di ristabilire, viene allentandosi; l'episcopato, sempre propenso alla
mondanità in tutto il medio evo, dà spesso esempio di vita corrotta; il clero
non é all'altezza della sua missione religiosa; gli Ordini mendicanti, che erano
stati la gloria del secolo antecedente, abbandonano la semplice regola dei primi
tempi, si arricchiscono, disdegnano l'umile missione tra i poveri, e si danno
alla predicazione aulica, o si trastullano con le vane sottigliezze di una
rinata sofistica.
La Scolastica, che con S. Tommaso d'Aquino aveva raggiunto il suo più perfetto
compimento, caduta ora in mano di discepoli senza genialità, si frantuma in una
casistica quasi puerile, o si sgretola sotto la dialettica di Duns Scoto e di
Guglielmo di Occam. Così si rivela la decadenza del pensiero
filosofico-teologico del medio evo, mentre va sorgendo nello studio e nella vita
quello spirito laico, che condurrà a poco a poco la società al naturalismo
teorico e pratico dell'Umanesimo.
In questi momenti così difficili, il Papato deve sostenere una duplice lotta:
religiosa contro l'eresia, politica contro l'Impero.
La lotta del Papato contro i Fraticelli
Da qualche tempo i Frati Minori sono in subbuglio.
Morto San Francesco, alcuni
tra i suoi discepoli cominciano a diffondere una più mite interpretazione della
regola e tendono a dare all'Ordine un'organizzazione simile a quella degli
altri Ordini religiosi; perciò edificano grandi chiese e vasti conventi,
accettano eredità e benefici, si dedicano allo studio nelle Università,
temperano insomma con le esigenze della realtà quotidiana la rigida severità del
primitivo ideale francescano.
Contro costoro, detti Conventuali, insorgono i discepoli della prima ora: questi
gridano al tradimento della regola, protestano in nome della povertà contro
l'ingordigia degli altri e negano ai veri Frati Minori il diritto di possedere.
Papa Clemente V cerca di mettere un po' di pace e impone ai dissidenti di
rientrare nell'Ordine; ma costoro, sentendo che il Papato è contro di essi,
vanno ancor più oltre con le loro affermazioni, attaccano il clero per la sua
mondanità, disprezzano i papi per le loro ricchezze, e proclamano che non i
Frati Minori solamente, bensì la Chiesa tutta deve ritornare alla povertà
evangelica. A drappelli percorrono i borghi e le campagne, sollevando le plebi
con il ricordo del poverello d'Assisi; si chiamano da sé Fraticelli.
Intanto ad Avignone, morto Clemente V, i cardinali hanno eletto un altro papa
francese, Giovanni XXII (1316-1334), ambizioso, amante dello sfarzo, fiero ed
energico nella lotta. Egli intuisce la minaccia che questi esaltati vanno
preparando alla Chiesa, e ne condanna le dottrine; poi arresta i ribelli,
parecchi ne fa bruciare sul rogo, e molti costringe alla fuga. Ma il movimento
rivoluzionario non si ferma; i perseguitati affrontano la guerra col Papato, e
offrono alleanza all'Impero, proprio nel momento in cui questo si accinge
all'ultima lotta politico-religiosa del medioevo.
La lotta tra il Papato e l'imperatore Lodovico il Bavaro
Alla morte dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo (1313), di nuovo la
Germania fu preda della discordia: si contendevano il trono Lodovico di
Wittelsbach, duca di Baviera, e Federico il Bello, duca d'Austria; da una parte
e dall'altra si combatteva con le armi e con gli intrighi.
Papa Giovanni XXII,
pieno delle vecchie idee di supremazia del Papato, impose ai due rivali di
sottoporre al suo giudizio inappellabile i loro diritti e quando, vinto il
nemico nella battaglia di Muhldorf (1322) e fattolo prigioniero, Lodovico si
proclamò re di Germania, il papa pretese che egli dovesse andargli a rendere
conto della validità della sua nomina. Lodovico IV il Bavaro si rifiutò, onde il
papa s'indusse a scomunicarlo, dichiarandolo decaduto dal trono e brigando per
dargli un successore (1324).
Erano proprio quelli i giorni dell'agitazione e della condanna dei Fraticelli.
L'imperatore si diede ad appoggiare gli eretici e a denunciare pubblicamente il
papa; poi accolse volentieri l'aiuto, che gli giungeva dagli uomini di lettere,
in mezzo ai quali si erano rinnovate in quei giorni le dispute sulle relazioni
tra il Papato e l'Impero.
Marsilio da Padova (1270-1342), intorno al 1324, cioé nei primi anni della
controversia tra Giovanni XXII e Lodovico, aveva scritto il trattato Defensor
pacis, nel quale, riprendendo in esame i rapporti tra l'Impero e la Chiesa, era
giunto a conclusioni gravissime e spesso in contrasto con le idee della
Monarchia dantesca, che forse di soli dieci anni é anteriore allo scritto di
Marsilio. Dante ha senza dubbio dell'Impero un concetto altissimo; non giunge
però mai a pretendere la soggezione del Papato all'Impero; dell'uno e dell'altro
poi afferma risolutamente la origine divina: Dante si muove ancora entro
l'orbita del pensiero politico-religioso medioevale.
Marsilio da Padova invece procede molto più avanti; spesso anzi si pone in
aperto contrasto col pensiero religioso del suo tempo, precorrendo di qualche
decennio le teorie ereticali di Wycliffe e di Huss, e accennando motivi polemici
che troveranno poi il loro più ampio sviluppo nella riforma di Lutero e di
Calvino. Il Defensor pacis non solo attacca le pretese di supremazia temporale
del Papato, ma nega a questo il primato spirituale, asserendo che fonte di ogni
potere nella Chiesa è il popolo, di cui l'imperatore è il solo legittimo
rappresentante, e affermando in tal modo la totale dipendenza della Chiesa dall'Impero.
Mentre Lodovico accoglieva alla sua corte il dotto giurista padovano, il papa
condannava il Defensor pacis (1327). La nuova lotta fra il Papato e l'Impero
trovò alimento nelle condizioni politiche d'Italia. Qui infatti a capo del
partito ghibellino era rimasto a lungo il potente Matteo Visconti, signore di
Milano, nominato già da Enrico VII vicario imperiale. Contro di esso il partito
guelfo aveva opposto Roberto d'Angiò, re di Napoli: a lui il papa, nella vacanza
dell'Impero, si era affrettato a conferire il titolo di vicario imperiale,
asserendo che solo chi dal papa fosse riconosciuto come tale, poteva portare
quel titolo. La guerra, dichiarata da papa Giovanni XXII a Matteo Visconti,
nemico della Chiesa e scomunicato, era stata condotta con qualche successo dal
legato pontificio, l'energico cardinale Bertrando del Poggetto; ma la morte
improvvisa di Matteo (1322) e l'avvento di Galeazzo Visconti, suo figlio,
avevano portato, dopo alcuni anni di lotta, ad una pace che aveva permesso
al legato papale di attendere alla riconquista dello Stato Pontificio, occupato da
innumerevoli tirannelli.
L'aspro conflitto, sorto fra il papa e Lodovico il Bavaro, riaccese nei
Ghibellini d'Italia il desiderio di riprendere la lotta: essi chiamarono in
Italia l'imperatore, il quale, accolto splendidamente da Galeazzo Visconti in
Milano, vi ricevette la corona di re d'Italia dalle mani di Guido Tarlati,
vescovo d'Arezzo, ribelle al papa (1327). Ma poi, fossero le riluttanze dei
milanesi alle continue richieste di danaro fatte dall'imperatore; fosse la
dubbia condotta di Galeazzo, certo è che Lodovico si rivelò improvvisamente
nemico dei Visconti, e, arrestato Galeazzo, lo fece chiudere nei Forni di Monza,
le orribili carceri che quegli aveva fatto costruire per i suoi nemici.
Lasciato a Milano un vicario imperiale, Lodovico il Bavaro passa in Toscana,
dove s'incontra con un altro potente ghibellino, Castruccio Castracani, signore
di Lucca: con lui l'imperatore assedia e prende Pisa, che gli vuole tagliare la
strada. Ogni resistenza è vinta : ormai non resta che cingere la corona
imperiale in Roma: nel gennaio 1328 Lodovico il Bavaro riceve dalle mani di
Sciarra Colonna, capitano del popolo, il serto imperiale: l'empio
schiaffeggiatore del vecchio Bonifacio VIII si sostituisce al pontefice,
dichiarando di conferire la corona imperiale a Lodovico in nome del popolo di
Roma. Così, secondo le recenti teorie di Marsilio da Padova, si tenta di dare al
Sacro Romano Impero una base popolare, e si crea un'antitesi a tutto il pensiero
politico-religioso del medio evo. In tale eccitazione di animi sbocciano la
ribellione e lo scisma: l'imperatore proclama deposto papa, Giovanni XXII, e,
per compensare del loro appoggio i Fraticelli, nomina antipapa, col nome di
Nicolò V, il loro capo, il minorita abruzzese Pietro da Corvara, uomo di poco
conto e male accetto al popolo romano.
La vittoria di Lodovico il Bavaro fu breve: da ogni parte i Guelfi rialzavano la
testa, mentre il partito ghibellino perdeva proprio in quei giorni il suo
maggiore sostegno, Castruccio Castracani. Questi era dovuto accorrere da Roma
in Toscana per difendere il suo Stato; ma, dopo brillanti vittorie era morto
improvvisamente (1328), lasciando le sue terre in pieno disordine, mentre il
legato papale Bertrando del Poggetto da Bologna minacciava con le sue forze
tutta la compagine ghibellina. L'imperatore, sentendosi ormai incalzato
dall'esercito di Roberto di Napoli, abbandonò Roma in gran fretta e passò a
Pisa, dove tentò invano di rialzare le sorti del suo partito. Ma l'equivoco
atteggiamento di Azzone Visconti, di Can Grande della Scala e dei Gonzaga di
Mantova gli tolse ogni speranza, per cui, raccolti più soldi che poté con la
vendita di feudi e di titoli, lasciò per sempre l'Italia, abbandonando il suo
antipapa alla mercé di Giovanni XXII e i suoi seguaci alle vendette dei Guelfi
(1330).
La lotta col Papato si trascinò per molti anni ancora, tra un ripetersi continuo
di scomuniche e di guerre civili, finché l'imperatore morì nel 1347, quando già
il papa Clemente VI, uno dei successori di Giovanni XXII, aveva fatto eleggere
Carlo IV di Boemia, della Casa di Lussemburgo.
Il nuovo sovrano era uomo ben diverso dal predecessore: dovendo al papa la sua
elezione, fu a lui fedele, e revocò quanto il Bavaro aveva fatto contro la
Chiesa. S'interessò poco dell'Italia, dove venne nel 1355 per prendere a Milano
la corona ferrea e a Roma la corona imperiale, senza però appoggiare i signori
ghibellini, che molto si aspettavano da lui. Anche Carlo IV partì dall'Italia
carico di soldi, ricevuti da città e da signori in compenso di privilegi
concessi e di titoli venduti.
La restaurazione dello Stato Pontificio; Cola di Rienzo; il ritorno dei papi
a Roma (1377).
Tra le aspirazioni dell'energico papa Giovanni XXII c'era anche la restaurazione
dello Stato Pontificio, allora occupato da molti signorotti. Egli aveva perciò
mandato in Italia il cardinale Bertrando del Poggetto, fornendolo di armati e di
danaro (1319), ed aveva potuto rallegrarsi per le felici operazioni di guerra
con cui il bellicoso cardinale era riuscito a riconquistare al papa Bologna e la
Romagna.
Il buon successo non fu però duraturo: i Visconti, gli Scaligeri e gli altri
maggiori Ghibellini d'Italia si opposero al legato papale fin quando lo videro
riprendere, sfiduciato, la via di Avignone (1334).
Il sogno del papa crollava. Lo Stato Pontificio non risorgeva. Bologna, caduta
sotto la signoria di Taddeo Pepoli, pareva perduta per sempre.
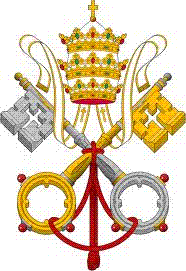
La Romagna, le Marche, l'Umbria pullulavano di piccole ma nervose Signorie, come
quelle dei Da Polenta a Ravenna, dei Malatesta a Rimini,
degli Ordelaffi a
Forlì, dei Manfredi a Faenza, dei Varano a Camerino, mentre per le desolate
campagne del Lazio spadroneggiavano i Colonna, i Caetani, i Savelli, i
Frangipani, gli Orsini; Roma poi era sempre il classico campo di lotta fra le
maggiori famiglie, e giaceva nella miseria e nel disordine.
Questa grande generale anarchia, durata per più di settanta anni (1305-1377),
contribuì a rendere ancor più difficile il ritorno dei papi, i quali, appunto
perché francesi, in generale sentivano poca attrazione per la vita di Roma e
d'Italia, e trovavano perciò una giustificazione di questo loro allontanamento
dalla sede naturale del Papato nella scarsa sicurezza dello Stato Pontificio.
L'effimera fortuna di Cola di Rienzo (1347 e 1354)
Proprio in quegli anni turbinosi emerse a Roma la singolare figura di un
popolano, Cola di Rienzo (= Nicola figlio di Lorenzo). Benché di umilissima
origine, egli ebbe una folle passione per lo studio delle antichità. Fin dalla
fanciullezza, aggirandosi fra i ruderi di Roma, si era riempita la testa con
storie degli antichi Romani e sognava un ritorno ai tempi repubblicani. Erano
queste le vaghe aspirazioni del nascente Rinascimento, ma in Cola di Rienzo tali
idee avevano un più vitale alimento dall'ostilità contro i nobili, nei quali
egli vedeva l'antica avidità dei patrizi, mescolata con la brutale violenza dei
signori feudali.
Egli fu dunque con il popolo contro le grandi famiglie nobili di Roma.
Nominato
dai papi notaro della Camera Apostolica, si servì di tale posizione per la
propaganda delle sue idee; nel 1347 con un abile colpo di mano abbatté i nobili,
assunse il titolo di tribuno del popolo e incominciò a governare Roma
ispirandosi alla democrazia, organizzando l'esercito popolano e amministrando
saggiamente la giustizia.
Vi fu un momento in cui la figura di Cola, sullo sfondo poetico dei ricordi
dell'antica Roma, apparve quasi un simbolo di rinascita per tutta l'Italia; onde
parecchi principi approvarono i suoi propositi di restaurazione, e anche il
Petrarca ebbe per lui profonda ammirazione. Disgraziatamente il rapido trionfo
tolse il senno a Cola, il quale si lasciò andare a stranezze e a vanterie
indecorose; di esse approfittarono i nobili che riuscirono a farlo cacciare
dalla città dopo appena pochi mesi di dominio (15 dicembre 1347).
Fuggendo da Roma, Cola di Rienzo si nascose nei pressi della Maiella, da dove
nascostamente si mosse attraverso l'Italia e le Alpi, per rifugiarsi in Boemia,
presso l'imperatore Carlo IV, il quale lo mandò al papa in Avignone. Là, dopo un
periodo di prigionia e di oscurità, l'intelligente tribuno entrò nelle grazie
del papa Innocenzo VI. Questi, che già aveva inviato in Italia per la
riconquista dello Stato Pontificio il cardinale Egidio di Albornoz, pensò di
valersi anche dell'opera di Cola nella restaurazione della sovranità papale
nella città eterna. Perciò gli concesse il titolo di senatore, cioè governatore
della città, e lo mandò a Roma (1354).
Erano passati sette anni dalla fuga del tribuno, ma il popolo non aveva
dimenticato quanto egli aveva fatto contro i nobili. Perciò Cola di Rienzo fu
accolto con favore dalla plebe, la quale si strinse intorno a lui per difenderlo
dalle insidie dei grandi. Ma anche questa volta il tribuno mostrò scarso
equilibrio: amante del lusso, si diede da fare per procurarsi soldi e giunse
fino al punto di tassare pesantemente il vino, il sale e le più comuni derrate.
Il popolo, sobillato dai nobili, si ribellò e diede l'assalto al Campidoglio:
Cola di Rienzo tentò di fuggire, travestito da carbonaio; ma, riconosciuto per i
braccialetti d'oro che portava, fu ucciso a furor di popolo ai piedi del
Campidoglio (8 ottobre 1354).
Il ritorno dei papi a Roma (1377)
L'opera di restaurazione nello Stato Pontificio rimase così tutta affidata all'Albornoz,
forte figura di guerriero più che di prelato, di diplomatico più che di
ecclesiastico. Egli in breve abbattè parecchie delle Signorie sorte nella
Romagna e nelle Marche, riscattò dai Visconti la città di Bologna, la difese
contro gli assalti di Bernabò Visconti, l'arricchì di privilegi e di donazioni
per il suo famoso Studio, fondandovi un collegio per gli studenti spagnoli.
Recatosi nelle Marche, e pacificate quelle regioni, nel 1357 tenne a Fano un
Parlamento, in cui riformò e unificò tutte le leggi dello Stato Pontificio,
formandone un codice, detto Liber Constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae, più
conosciuto col nome di Constitutiones Aegidianae, che rimase il fondamento della
legislazione nello Stato della Chiesa fino ai tempi moderni. A Roma riformò la
costituzione comunale, ristabilì l'ordine, cosicché nel 1367 papa Urbano V pensò
giunto il momento di ricondurre a Roma la corte pontificale.
Vi arrivò infatti
in mezzo all'esultanza delle popolazioni; lo stesso imperatore Carlo lV venne
dalla Germania per fargli omaggio; ma essendo morto l'Albornoz e rinascendo di
continuo le contese e i disordini in Roma, il papa, dopo appena tre anni
(1367-1370), ritornò ad Avignone. Il successore, Gregorio XI, cominciò assai male il suo pontificato mandando in
Italia alcuni legati, troppo lontani dall'Albornoz nell'abilità politica: tra
essi ebbe triste fama il cardinale Roberto di Ginevra, che compì orribili stragi
a Cesena. Il pontefice si inimicò anche la città di Firenze che, interdetta e
perseguitata, inalberò contro il papa la bandiera della libertà (guerra degli
Otto Santi). Finalmente ritornata la calma, Gregorio XI riportò a Roma
definitivamente la sede papale (1377), ponendo termine alla cattività avignonese.
Lo Scisma d'Occidente (1378) e i Concili di Costanza (1414-1418) e di Basilea
(1431-1449).
Un male, forse ancora più grave della cattività avignonese, sovrastava in quei
giorni alla Chiesa: lo scisma.
Morto Gregorio Xl (1378), si raccolse, per la
elezione del successore, il Sacro Collegio, composto di sedici cardinali, di cui
solo quattro italiani, mentre gli altri erano quasi tutti francesi.
Allora il popolo romano, che temeva la nomina di un papa francese e il ritorno
della sede pontificia ad Avignone, cominciò a tumultuare sotto le finestre del
conclave, gridando minaccioso : — Romano lo volemo o almanco italiano! —
I cardinali, per evitare maggiori guai, si piegarono ai clamori del popolo ed
elessero Bartolomeo da Prignano, arcivescovo di Bari, che prese il nome di
Urbano VI (1378). Ma essendo questi assai duro di modi, parecchi cardinali
francesi, cominciarono dopo qualche settimana a spargere dubbi sulla validità di
un'elezione avvenuta sotto la minaccia del popolo; quindi, fatta tra loro una
congiura, dichiararono Urbano VI papa illegittimo e, radunatisi a Fondi, là
elessero il noto cardinale Roberto di Ginevra, prelato assai giovane, mondano e
superbo, odiatissimo in Italia per le crudeltà commesse a Cesena. L'antipapa
assunse il nome di Clemente VII; costretto a rifugiarsi a Napoli, tentò di
schiacciare il rivale con l'aiuto dei suoi Bretoni e della regina Giovanna I,
fautrice dello scisma; non riuscendovi, tornò in Francia, dove aprì gran corte
nel palazzo papale di Avignone (1379).
Così la Chiesa si divise in due parti: il papa di Roma ebbe intorno a sé i
fedeli dell'Italia centrale e settentrionale, della Germania, della Polonia,
dell'Ungheria, dell'Inghilterra, del Portogallo; l'antipapa di Avignone fu
riconosciuto dalla Francia, dalla Savoia, dall'Aragona, dalla Castiglia e dal
Regno di Napoli. Il prestigio e l'autorità del Papato caddero allora assai in
basso; lo si vide nel rapido diffondersi di alcune eresie, come quella di
Giovanni Wycliffe in Inghilterra e più tardi di Giovanni Huss in Boemia. Lo
scandalo per tutta la Chiesa giunse a tal punto, che eminenti personaggi, laici
ed ecclesiastici, credettero di dovere intervenire per ricondurre la pace
religiosa. Nel 1409 si raccolse pertanto a Pisa un concilio, il quale però,
invece di definire la contesa, diede alla cristianità un terzo papa, eleggendo,
senza avere ottenuta la rinunzia degli altri pontefici, il cardinale Pietro
Filargo, greco di origine, arcivescovo di Milano: egli prese il nome di
Alessandro V e pose la sua sede a Bologna.
Così la cristianità, anziché in due parti, si divise in tre, poiché i due papi,
che il Concilio di Pisa aveva, di propria autorità, deposti, non riconobbero
come legittime le decisioni conciliari.
Non a torto, perché in quel Concilio,
a base di tutto era stata posta una teoria, difesa allora da parecchi teologi,
ma combattuta sempre dai papi, che cioé il Concilio fosse superiore al pontefice
e avesse quindi il diritto di controllarne l'attività e anche di deporlo: la
monarchia assoluta dei papi si sarebbe trasformata così in una oligarchia.
La sospirata conciliazione, anziché avvicinarsi, sembrava farsi ogni giorno più
lontana, perché ciascuno dei tre papi, per accrescere la propria influenza
eleggeva sempre nuovi cardinali, concedeva ai principi titoli e privilegi,
elargiva alle popolazioni indulgenze e favori. Ad aumentare la confusione del
momento concorsero la morte del mite e pio Alessandro V, l'eletto di Pisa, e la
fulminea elezione del suo successore Giovanni XXIII (1410), prelato intrigante,
mondano, ambiziosissimo, il quale doveva poi essere il più implacabile nemico
della conciliazione e della pace religiosa.
Il Concilio di Costanza (1414-1418) e la fine dello Scisma d'Occidente.
Il Concilio di Pisa aveva fatto obbligo al papa Alessandro V di convocare un
Concilio ecumenico per provvedere all'estinzione reale dello scisma e alla
definitiva riforma della Chiesa. Ciò che la morte aveva impedito ad Alessandro
V, fu invece costretto a fare il suo successore, anche perché l'imperatore
Sigismondo glielo impose energicamente. Giovanni XXIII convocò dunque il
Concilio a Costanza, città comoda a tutti i tre i contendenti e vigilata dallo
stesso imperatore (XVI Concilio ecumenico 1414-1418). Il papa di Roma diede il
suo consenso; l'antipapa di Avignone rimase invece sordo ad ogni ragione.
Giovanni XXIII, fiducioso di esser lui il preferito, appoggiò il Concilio; ma
quando si accorse delle ostilità che l'assemblea aveva verso di lui, fuggì da
Costanza, disdisse il Concilio e cercò di sollevare i suoi amici per evitare la
catastrofe, che sentiva imminente. Ma il Concilio, ormai convocato e forte
dell'appoggio imperiale, cominciò ad agire energicamente per ottenere
l'abdicazione di tutti e tre i papi e per procedere poi a una definitiva elezione
(1415). Il ribelle Giovanni XXIII fu allora inseguito, arrestato dai cavalieri
imperiali e costretto a sottoscrivere la sua rinuncia; il papa di Roma, il pio
Gregorio XII, spontaneamente abdicò; l'antipapa avignonese, sempre ostile, fu
deposto come ribelle. Così, sempre in mezzo a non lievi difficoltà, il Concilio
procedette all'elezione del papa, che fu il cardinale Ottone Colonna, romano, il
quale prese il nome di Martino V (1417) e fu riconosciuto da tutta la
cristianità.
Il Concilio, prima ancora di eleggere il nuovo papa, aveva cominciato una
energica epurazione della Chiesa: le idee dell'inglese Wycliffe, morto fin dal
1384, e del boemo Huss erano state prese in esame e condannate come ereticali;
Giovanni Huss, arrestato a Praga, aveva lasciato la vita sul rogo (1415).
Nominato il pontefice, il Concilio volle proseguire nella riforma della Chiesa,
in capite et in membris (come si diceva allora), cioé dal papa fino agli ultimi
fedeli. Questa riforma, da tanto tempo richiesta, era davvero necessaria, perché
nel lungo periodo dello scisma la moralità dell'alto e del basso clero era
spaventosamente decaduta; il momento scelto per una riforma così grave non parve
però opportuno al nuovo pontefice e a quanti temevano il rinnovarsi di
discordie, foriere di nuovi scismi.
Si avverti allora un urto fra Martino V,
deciso a mantenere la propria supremazia spirituale, e il Concilio, risoluto a
voler governare esso la Chiesa e a dirigere il pontefice, secondo la teoria,
condivisa da molti vescovi e dottori, della superiorità del Concilio sul papa.
Martino V evitò ogni dichiarazione di massima e con molta abilità avviò il
Concilio alla chiusura (1418): quello però non si sciolse, se non dopo avere
imposto al papa l'obbligo di convocare nell'anno 1423 un nuovo Concilio a Pavia.
Queste complicate vicende dimostravano che, pur essendo estinto lo scisma,
rimanevano tuttora attive le cause, che potevano da un momento all'altro farlo
rivivere.
Il Concilio di Basilea (1431-1449) e la ripresa dello Scisma d'Occidente
Martino V seppe un'altra volta disciogliere il Concilio, convocato nel 1423 a
Pavia, e per parecchi anni riuscì a calmare le pretese degli zelanti,
interessati forse più a rinnovare disordini che a riformare la Chiesa; tuttavia
non poté esimersi dal convocare un nuovo Concilio a Basilea per il 1431. Mentre
cardinali, vescovi, dottori si avviavano a quel consesso, papa Martino V moriva.
Toccò dunque al suo successore, il veneziano Eugenio IV (Gabriele Condulmer), il
grave compito di affrontare un'assemblea, i cui memori più influenti erano a lui
ostili e convinti della superiorità del Concilio sul papa. Egli si provò a
trasportare il Concilio a Bologna, per vigilarlo meglio, ma dovette desistere
dal suo proposito di fronte alla aperta ribellione dei prelati e questi
cominciarono a legiferare sulla Chiesa senza fare gran calcolo del papa.
Più tardi però si offerse al pontefice una buona occasione per riprendere l'idea
del trasferimento. Da qualche tempo infatti l'avanzata dei Turchi nella Tracia
minacciava così da vicino Costantinopoli, che l'imperatore d'Oriente, incapace
ormai di difendersi, aveva dovuto ricorrere al papa e a tutta la cristianità
perché si facesse una grande Crociata contro gli infedeli; per commuovere più
facilmente il pontefice, l'imperatore si offriva di compiere l'unione della
Chiesa greca con la latina, vagheggiata da tanto tempo dai papi.
L'affare era di tale importanza, che Eugenio IV volle trattarlo davanti al
Concilio: ma siccome questo si trovava a Basilea, città troppo scomoda per i
plenipotenziari greci giunti appositamente in Italia, il papa ordinò il
trasferimento del Concilio prima a Ferrara, poi a Firenze. Si vide allora come
fosse sempre vivo lo spirito scismatico e ribelle: mentre i più autorevoli fra i
prelati obbedivano al papa, alcuni, non si piegarono, proclamarono la
superiorità del Concilio sul papa, deposero Eugenio IV ed elessero antipapa
Amedeo VIII, duca di Savoia, che prese il nome di Felice V (1439).
Intanto a Firenze, dove erano convenuti anche l'imperatore d'Oriente, Giovanni
VIII Paleologo, e il patriarca di Costantinopoli, si proclamava l'unione della
Chiesa greca con la romana (1439), unione che praticamente non si fece mai per
l'opposizione degli stessi Greci.
Morto poi Eugenio IV (1447), il successore
Nicolò V, accordatosi con l'imperatore Federico III d'Austria, faceva cacciare a
forza da Basilea i pochi prelati, che ancora vi si trovavano a concilio, mentre
Felice V spontaneamente abdicava e si sottometteva al papa (1449).
Egli fu
l'ultimo antipapa nella storia del pontificato romano.
Così finiva lo Scisma d'Occidente. Da esso il Papato era uscito vittorioso, dopo
un periodo di crisi, tra i più spaventosi che ricordi la storia della Chiesa. Ma
la riforma, tanto invocata e tanto necessaria, non venne: non la promosse allora
il Papato, che temeva il risorgere delle pretese del Concilio; non la desiderò,
in generale, l'alto clero, distratto ormai dalle seduzioni del Rinascimento.
Romania
Durante il XIV secolo, nello spazio dell'antica
Dacia, si formarono i principati di Valacchia, nel 1330 circa, e Moldavia, nel
1359 circa.
Nel 1235 fu fondato il patriarcato bulgaro, nel
1346 fu fondato quello Serbo.
|
|